 |
| Pedemontana Tratta B2 e la tangenziale Meda-Seregno |
Abbiamo ricevuto dal sig. Enrico Radice una serie di documenti e riflessioni articolate riguardanti il progetto della Tangenziale di Meda Sud/Seregno, un’opera stradale collegata alla più ampia infrastruttura dell’Autostrada Pedemontana Lombarda. Quella della tangenziale è una vicenda che parte da lontano, con proposte alternative già formulate oltre un decennio fa, e che è tornata oggi al centro dell’attenzione pubblica grazie all’incontro organizzato a Seregno lo scorso 22 luglio 2025.
Nel testo che segue, riproponiamo integralmente l’intervento del sig. Radice, accompagnato da riferimenti puntuali ad altri documenti tecnici e civici elaborati negli anni da comitati di quartiere, associazioni territoriali e studi di pianificazione.
L’incontro su Pedemontana a Seregno: una lezione di democrazia partecipativa (di Enrico Radice)
 |
| Il sindaco Alberto Rossi |
Organizzato come Seregno sa fare, l’incontro del 22 luglio u.s. tra cittadini, Presidenti dei Comitati di Quartiere, rappresentanti del Parco GruBria, l’Assessore Borgonovo, il Sindaco Rossi (regista dell’incontro) e i vertici di Autostrada Pedemontana Lombarda, si è svolto nella splendida cornice dei giardini della biblioteca Pozzoli.
Seregno, come tanti altri comuni – vedi Lesmo, Biassono, Seveso (per menzionare i più recenti) – si è attivata per un doveroso confronto informativo a beneficio dei propri cittadini. Considerato che Seregno sarà attraversata da soli 300 metri in galleria e trincea, ho cercato di immaginare quali e quanti ben altri confronti avrebbe dovuto organizzare Meda, considerata la bonifica in corso per l’evento Icmesa, la lunghezza del percorso sul territorio comunale, l’adeguamento del più importante svincolo del tracciato (che si rinnoverà e si amplierà per supportare la chiusura dello svincolo di Seveso).
Il cuore del dibattito: la tangenzialina di Meda
Nell’incontro a Seregno, infatti, l’argomento maggiormente discusso e oggetto di generale contrarietà è stato il tracciato della tangenzialina di Meda:
Arturo Lanzani, presidente del Parco GruBria: “Noi abbiamo messo in discussione la tangenziale di Meda, abbiamo fatto delle proposte che non sono state recepite. È stata però recepita l’eliminazione di una rotatoria che immetteva su due strade vicinali.”
Andrea Monguzzi, responsabile ufficio tecnico Pedemontana: “Il Comune di Seregno ha chiesto l’eliminazione dell’opera ma il Comune di Meda la vuole. È stata concordata l’eliminazione di una rotatoria: al suo posto ci sarà una curva di raccordo.”
 |
| Progetto modificato senza rotonda (Meda, al confine con il Parco del Meredo) |
Alberto Rossi, Sindaco di Seregno: “Quei 10.800 mq nel parco del Meredo, che saranno occupati dall’opera, per noi, sono di troppo. Lo abbiamo detto fin da subito. Abbiamo fatto delle proposte alternative, ma sono state rifiutate.” “La tangenziale è già entrata in fase preliminare di cantiere, in anticipo rispetto all’opera principale (Pedemontana). Una decisione che ha colto di sorpresa il Comune di Seregno.”
Un progetto invasivo, nato in sordina
Il progetto originario – definito in una slide dell’ing. Monguzzi come “concordato” (tra chi non è dato saperlo) – si sviluppa dall’incrocio di via Indipendenza di Meda e via Cadore di Seregno con via Vignazzola di Seveso/Meda. I lavori sono già in corso per un tracciato invasivo del Parco Brianza Centrale/GruBria, e soprattutto delle aree verdi dei Quartieri Polo e Meredo per una superficie indicativa di circa 50.000 mq.
 |
| In azzurro: progetto alternativo alla tangenziale Meda-Seregno |
Numerosi sono stati i richiami al tracciato alternativo incentrato sulla via Gorizia, già progettato nel 2010 dall’Associazione Cittadini Quartiere Polo (Presidente sig.ra Elena Basso) e dal Centro Promozione Brianza di Cabiate (Presidente ing. Elio Turati), con la collaborazione dello studio di pianificazione territoriale Logos Loci, e presentato alle commissioni territorio della Provincia di Monza e della Regione Lombardia.
Questa proposta, più volte aggiornata (anche nel 2019 e 2023), prevedeva l’utilizzo della viabilità esistente, la tutela delle aree verdi e una drastica riduzione dei costi per espropri e opere (fino al -70%, come riportato nel documento “Svantaggi e Vantaggi” del dicembre 2023). Una soluzione che avrebbe anche garantito maggiore sicurezza e fluidità del traffico, evitando di congestionare zone delicate come via Tre Venezie e il polo scolastico.
Un'opera imposta? Le domande senza risposta
Sul tema, le stesse associazioni avevano già inoltrato nel 2015 un esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Milano, per un’indagine volta all’accertamento dell’ingente inutile dispendio economico richiesto per la realizzazione dell’opera così progettata.
Ci si chiede pertanto: chi insista oggi per questo tracciato della tangenzialina, che toglie ai cittadini 50.000 mq di aree verdi (convertibili in edificabili?), soffocando ancora di più il Quartiere Polo tra svincolo, FSI e tangenzialina, e costringendolo – nel caso – a chiedere un sovrappasso pedonale per poter usufruire del parco Brianza Centrale/GruBria.
Le opere di Pedemontana: tangenzialina di Meda e la soluzione alternativa del Centro Promozione Brianza, dell'Associazione Cittadini Quartiere Polo e dello studio di pianificazione territoriale Logos Loci del 2014
Svantaggi del progetto Pedemontana
- viabilità invasiva delle residenze di via Forlì/Polo
- maggiori costi del 70% per espropri ed opere
- tempi lunghi di realizzazione per imprevisti e percorso
- tracciato pericoloso con oltre 100 attraversamenti vie Vignazzola e Meredo
- riduzione del verde esistente di Seveso, Meda e del Parco Brianza Centrale
- aumento di traffico su via Tre Venezie (vd. scuole, Palameda, residenze, aziende)
- invadenza delle zone residenziali dei Quartieri Meredo di Seveso e Polo di Meda
Vantaggi della proposta alternativa
- viabilità e opere di urbanizzazione esistenti
- diminuzione del percorso e dei tempi di realizzazione
- tracciato largo, sicuro e con esigui attraversamenti su un lato
- abbattimento del 70% dei costi per espropri ed opere
- tutela del verde esistente di Seveso, Meda e del Parco Brianza Centrale
- fluidificazione del traffico, tempi ed emissioni ridotte
- rispetto delle zone residenziali dei Quartieri Meredo di Seveso e Polo di Meda
 |
| Per leggere tutti i post riguardanti la tangenziale Meda-Seregno cliccare qui |



























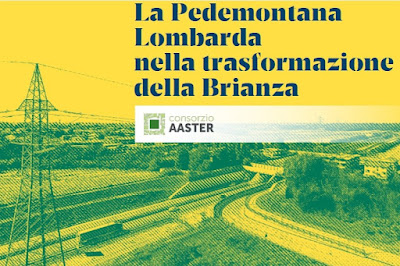










.jpeg)






